|
|
|
|
|
Galleria Tassonomica
di
Natura Mediterraneo
|
|
|
| Autore |
 Discussione Discussione  |
|
ang
Moderatore
    

Città: roma
Regione: Lazio

11353 Messaggi
Tutti i Forum |
 Inserito il - 09 gennaio 2011 : 19:09:46 Inserito il - 09 gennaio 2011 : 19:09:46


|
auguri peter!  
ciao
ang |
 |
|
|
Fabiolino pecora nera
Moderatore
    

Città: Napoli
Prov.: Napoli
Regione: Campania

5000 Messaggi
Biologia Marina |
 Inserito il - 09 gennaio 2011 : 23:31:48 Inserito il - 09 gennaio 2011 : 23:31:48


|
Al volo...gli esemplari determinati nel libro come lucens sono effettivamente loro (lo scrivo giusto per escludere errori di ID) e la ex Tapes aurea è stata spostata di genere (in Polititapes aureus) e la T. lucens è considerata soltanto una forma della aurea in base al fatto che non esistono differenze in forma, denti e seno palleale rispetto alla molto variabile Tapes aurea ed è possibile creare una serie di esemplari (credo con la aurea) da molto sculturati a lisci.
Levatemi tutto ma non il mio mare... |
 |
|
|
PS
Utente Senior
   

Regione: Friuli-Venezia Giulia

4462 Messaggi
Biologia Marina |
 Inserito il - 10 gennaio 2011 : 08:29:10 Inserito il - 10 gennaio 2011 : 08:29:10


|
| Messaggio originario di Fabiolino pecora nera:
E' recentemente uscito "Compendium of Bivalves", un mattone di 1000 pagine e dal costo di 150 euro, ad opera di Markus Huber. L'approccio mi sembra abbastanza "morfologico", ma non sono assolutamente in grado di controbattere scientificamente a quanto proposto se non nella metodologia utilizzata, ad esempio, per alcuni cambi di generi (contenti tutti?  claudio va bene come ho scritto o pensi che sia il caso di farci un altro paio di pal...ehm, sermoni riguardo la mancata educazione che ho ricevuto dai miei genitori?). Qui vengono cambiati i generi e gli epiteti specifici di tantissime specie, anche mediterranee, di altre viene confermata la validità specifica e di molte specie si assiste anche ad ampliamento di areale (tipo non vorrei sbagliarmi perchè ho fatto indigestione e ci vorranno 2 mesi per capire tutto, ma ad esempio Jolya martorelli (ex Modiolus martorelli) è dato per l'Italia, il Laevicardium castaneum è considerato specie mediterranea valida and so on....). claudio va bene come ho scritto o pensi che sia il caso di farci un altro paio di pal...ehm, sermoni riguardo la mancata educazione che ho ricevuto dai miei genitori?). Qui vengono cambiati i generi e gli epiteti specifici di tantissime specie, anche mediterranee, di altre viene confermata la validità specifica e di molte specie si assiste anche ad ampliamento di areale (tipo non vorrei sbagliarmi perchè ho fatto indigestione e ci vorranno 2 mesi per capire tutto, ma ad esempio Jolya martorelli (ex Modiolus martorelli) è dato per l'Italia, il Laevicardium castaneum è considerato specie mediterranea valida and so on....).
Tantissimi auguri a chi si vorrà cimentare prima nel comprarlo e poi nell'isolare i cambiamenti riguardanti la nostra fauna.
Allo stesso tempo su The Veliger è uscito un simpatico articolo di Criscione e Patti riguardo Rissoa lia/Rissoa guerini:
F. CRISCIONE and F. P. PATTI. Similar shells are not necessarily a reliable guide to phylogeny: Rissoa guerinii Récluz, 1843, and Rissoa lia (Monterosato, 1884) (Gastropoda: Rissoidae): a case study: 117-128
che io consiglierei vivamente di leggere
|
Garzie per le segnalazioni.
Purtroppo per me non ho il volumone sui bivalvi, quindi non sono in grado di aggiornare la relativa lista. Se qualche buon anima mi dirà cosa andrebbe cambiato, magari un po' per volta, sarò ben lieto di aggiornare la lista.
Riguardo all'articolo sui Rissoidae, dove si può trovarlo, sarei decisamente interessato.
Link
|
 |
|
|
Fabiolino pecora nera
Moderatore
    

Città: Napoli
Prov.: Napoli
Regione: Campania

5000 Messaggi
Biologia Marina |
 Inserito il - 10 gennaio 2011 : 09:31:26 Inserito il - 10 gennaio 2011 : 09:31:26


|
Sì ma onestamente non so proprio come regolarmi. Infatti, mentre uscivano i lavori di La Perna sui Cardidae in cui lo status di A. deshayesii ad esempio è convalidato, allo stesso tempo nel Compendium A. deshayesii è messo in sinonimia con echinata...
Levatemi tutto ma non il mio mare... |
 |
|
|
PS
Utente Senior
   

Regione: Friuli-Venezia Giulia

4462 Messaggi
Biologia Marina |
 Inserito il - 10 gennaio 2011 : 09:56:34 Inserito il - 10 gennaio 2011 : 09:56:34


|
| Messaggio originario di Fabiolino pecora nera:
Sì ma onestamente non so proprio come regolarmi. Infatti, mentre uscivano i lavori di La Perna sui Cardidae in cui lo status di A. deshayesii ad esempio è convalidato, allo stesso tempo nel Compendium A. deshayesii è messo in sinonimia con echinata...
Levatemi tutto ma non il mio mare...
|
Caro Fabio, questi sono i "soliti" problemi. Io in genere mi comporto così;
prima leggo gli articoli in questione, poi in base a quello che mi sembra "più convincente" faccio le mie scelte. L'ideale sarebbe che l'articolo più recente prendesse in esame quello immediatamente precedente, ma purtroppo questo non accade sempre.
Ad esempio non ho adottato tutte le modifiche sul genere Chauvetia riportate nei lavori recenti fatti da alcuni autori spagnoli....
Certamente dal punto di vista scientifico questo mio modo di operare lascia molto a desiderare, ma in presenza di evidenti incoerenze non saprei cosa altro fare.
Link
|
 |
|
|
Ermanno
Moderatore
    
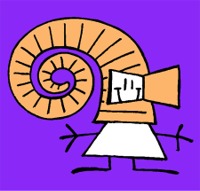
Città: Longare
Prov.: Vicenza
Regione: Veneto

6437 Messaggi
Biologia Marina |
 Inserito il - 23 maggio 2011 : 10:14:39 Inserito il - 23 maggio 2011 : 10:14:39


|
Nel n° 71 della rivista: Malacologia, mostra mondiale, Cupra Marittima, c'è la descrizione di un nuovo Calliostoma mediterraneo .... : Calliostoma funiculatum Ardovini, 2011.
Si tratta di una piccola specie a conchiglia elevata, con le prime spire percorse da 3-4 file di granuli che poi "mutano" in quattro funicoli lisci (oltre al cordone basale) costanti fino all'apertura; la base è percorsa da numerosi cordoncini concentrici separati tra loro da sottili solchi; l'opercolo differisce da quello di laugeri e zizyphinum per consistenza e numero di spire ....
La specie è stata istituita su alcuni esemplari raccolti nel 1999 , a 70 metri di profondità su fondale coralligeno ad ovest delle isole Egadi.
Un'immagine dell'olotipo la potete trovare qui:
Link
Alcune considerazioni a caldo .... io penso che la specie sia buona ... che sia stata generalmente classificata come una forma di C. planatum (Pallary, 1900) = T. dubium Philippi (fide autori spagnoli) ... e che a dispetto di quanto riportato dall'autore, presenti una variabilità ben più ampia (come tutte le bestiacce del gruppo)... ma per esserne certo dovrò confrontare i miei esemplari con il tipo.
Come critiche ...: nella discussione del taxon, dei confronti "all'acqua di rose", specialmente per la specie di un gruppo sul quale sono stati versati mari di inchiostro per le descrizioni di forme e specie ... magari non presenti nei lavori di sintesi dei nostri tempi, ma che dovrebbero essere obbligatoriamente consultati e cogitati prima del battezzare qualsiasi nuova bestiola ...
Ermanno
|
 |
|
|
Stepa
Utente Senior
   
Città: Pescara
Regione: Abruzzo

2965 Messaggi
Tutti i Forum |
 Inserito il - 08 ottobre 2011 : 01:48:05 Inserito il - 08 ottobre 2011 : 01:48:05


|
Neosimnia sp. Schiaparelli et al.(2005) del nostro elenco sistematico dovrebbe essere il morfotipo B di Neosimnia spelta.
Nel suo lavoro sulla sistematica degli ovulidi (Spixiana 30,1 pagg.121-125), Dirk Fehse la identifica con Neosimnia illyrica Schilder,1927.
Il CLEMAM, ma non solo lui, già da tempo ha adottato questa nomenclatura.
Non è il caso di aggiornare anche la lista?
Ciao
Stefano |
 |
|
|
PS
Utente Senior
   

Regione: Friuli-Venezia Giulia

4462 Messaggi
Biologia Marina |
 Inserito il - 10 ottobre 2011 : 09:11:19 Inserito il - 10 ottobre 2011 : 09:11:19


|
| Messaggio originario di Stepa:
Neosimnia sp. Schiaparelli et al.(2005) del nostro elenco sistematico dovrebbe essere il morfotipo B di Neosimnia spelta.
Nel suo lavoro sulla sistematica degli ovulidi (Spixiana 30,1 pagg.121-125), Dirk Fehse la identifica con Neosimnia illyrica Schilder,1927.
Il CLEMAM, ma non solo lui, già da tempo ha adottato questa nomenclatura.
Non è il caso di aggiornare anche la lista?
Ciao
Stefano
|
FATTO!
Grazie per la segnalazione.
Link
|
 |
|
|
Stepa
Utente Senior
   
Città: Pescara
Regione: Abruzzo

2965 Messaggi
Tutti i Forum |
 Inserito il - 24 ottobre 2011 : 01:45:58 Inserito il - 24 ottobre 2011 : 01:45:58


|
Il CLEMAM sostiene che la nomenclatura Mangelia tenuicostata (Brugnone,1868) è frutto di un errore e che si dovrebbe adottare Mangelia tenuicosta (Brugnone,1862). Ha ragione?
Ciao
Stefano |
 |
|
|
myzar
Utente Senior
   
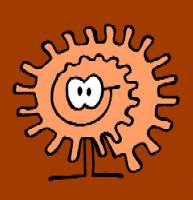
Città: Livorno
Prov.: Livorno
Regione: Toscana

3886 Messaggi
Biologia Marina |
 Inserito il - 24 ottobre 2011 : 10:00:30 Inserito il - 24 ottobre 2011 : 10:00:30


|
| Messaggio originario di Stepa:
Il CLEMAM sostiene che la nomenclatura Mangelia tenuicostata (Brugnone,1868) è frutto di un errore e che si dovrebbe adottare Mangelia tenuicosta (Brugnone,1862). Ha ragione?
Ciao
Stefano
|
Sì.
myzar |
 |
|
 Discussione Discussione  |
|
|
|
 Natura Mediterraneo Natura Mediterraneo |
© 2003-2024 Natura Mediterraneo |
 |
|
Leps.it | Herp.it | Lynkos.net
|

 Forum
|
Registrati
|
Msg attivi
|
Msg Recenti
|
Msg Pvt
|
Utenti
|
Galleria |
Map |
Forum
|
Registrati
|
Msg attivi
|
Msg Recenti
|
Msg Pvt
|
Utenti
|
Galleria |
Map |